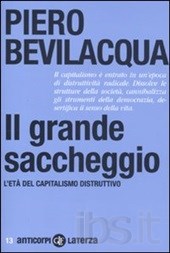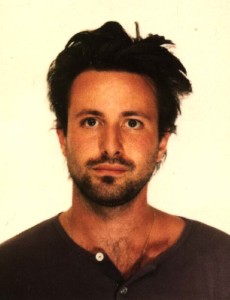Il fotoreporter napoletano Luciano Ferrara è il quinto protagonista di “Creatività meridiane”, il ciclo di incontri di Danilo Chirico con intellettuali, artisti, politici, semplici cittadini meridionali che hanno piccole e grandi esperienze da raccontare alla ricerca di nuove idee, memorie disperse e buone pratiche. “Creatività meridiane” è un tentativo di fare un racconto autentico del Mezzogiorno, un modo di provare a scrivere parole inedite sul Sud, un contributo a un ragionamento – collettivo e individuale – sempre più urgente: ricostruire un’originale identità meridionale. In un Paese davvero unito.
 «Terra di sperimentazione e sofferenza». È una definizione bella, suggestiva e convincente quella che Luciano Ferrara usa per descrivere il Sud del nostro Paese. Terra capace di grandi innovazioni, spesso costretta a pagare un prezzo alto, «come nel caso dell’Unità d’Italia che stiamo festeggiando proprio in questi mesi», precisa subito. «Il Mezzogiorno ha dato un grande contributo all’Unità – spiega – e anche al Nord. Non vorrei dimenticare che i “nordisti” oltre alle braccia meridionali si sono portati a casa le casse piene di denari. Se non lo diciamo, non capiamo in che Paese viviamo».
«Terra di sperimentazione e sofferenza». È una definizione bella, suggestiva e convincente quella che Luciano Ferrara usa per descrivere il Sud del nostro Paese. Terra capace di grandi innovazioni, spesso costretta a pagare un prezzo alto, «come nel caso dell’Unità d’Italia che stiamo festeggiando proprio in questi mesi», precisa subito. «Il Mezzogiorno ha dato un grande contributo all’Unità – spiega – e anche al Nord. Non vorrei dimenticare che i “nordisti” oltre alle braccia meridionali si sono portati a casa le casse piene di denari. Se non lo diciamo, non capiamo in che Paese viviamo».
Luciano Ferrara è un fotoreporter napoletano di fama internazionale. Che sta da sempre tra la gente, dentro la società, dentro le trasformazioni sociali e culturali. Ha attraversato il movimento operaio e quello per la pace di Comiso, ha immortalato la guerra del Golfo e le bombe in Libano, ha scoperto il movimento dei disoccupati napoletani e raccolto il volto dei “femminielli”, ha raccontato come pochi Napoli e la Campania. Ha uno sguardo personale, originale sui fenomeni meridionali. Utile a cogliere l’essenza dei cambiamenti. «Innanzitutto bisogna dividere la parte politica dalla parte sociale», premette. E spiega: «In politica, a parte piccole cose in Puglia, non ci sono grosse novità in questo momento». Ben diverso il discorso nei movimenti sociali, «che sono vivi, fatti di giovani e che sanno fare proposte». Che si scontrano con un limite: «Non riescono a stare in rete tra loro e soprattutto a trovare un collegamento con il resto dell’Italia». Che non hanno memoria di ciò che è stato: «La mia generazione, quella degli anni Settanta – chiarisce – ha sperimentato molte cose di cui oggi purtroppo non è rimasta traccia». Colpa di chi dimentica, colpa anche «delle istituzioni che hanno completamente cancellato questo protagonismo». Luciano Ferrara denuncia cioè la distruzione «del laboratorio stradale». Napoli «è la città del teatro, della musica, di molte altre cose – sottolinea – e questo è accaduto perché in quello che io chiamo il laboratorio stradale, nei sotterranei, nel retroterra c’era una sperimentazione forte, c’era lo spazio per fare crescere le sensibilità». Le istituzioni hanno cancellato tutto, secondo Ferrara. «La colpa della politica, anche di quella di centrosinistra, è stata puntare tutto sui grandi eventi e non fare crescere quello che si muoveva dentro Napoli», sotto Napoli. La vera ricchezza culturale di una città straordinaria. L’avvento della destra alla Regione ha fatto il resto: «Hanno fatto un taglio drastico sulla cultura». C’è stato immediatamente un cambio al vertice al teatro Mercadante e «un museo importantissimo a livello mondiale come il Madre ha avuto una riduzione del budget a un milione e mezzo di euro. Pochissimo. Un vero e proprio attacco alla cultura dovuto soltanto alla necessità di liberarsi di 15 anni di potere di Bassolino. Senza alcun progetto». Lo dimostra anche il caso del teatro Trianon diretto da Nino d’Angelo, oggi incomprensibilmente chiuso.
C’è la possibilità di invertire la rotta. Una possibilità gigantesca che si chiama Forum internazionale delle culture, un grande evento che dopo Barcellona arriverà a Napoli nel 2013: «È una grande occasione – sottolinea Ferrara – arriveranno milioni e milioni di euro, venti milioni di visitatori. C’è la possibilità di cambiare il volto della città». Ma la domanda «che ci dobbiamo porre è: che cosa vogliamo mostrare? Qual è l’indirizzo culturale?». Una proposta Ferrara, insieme a un gruppo di fotografi, l’ha fatta: «Lavorare sulla memoria storica del nostro territorio con una grande mostra fotografica che racconti Napoli dal 1900 a oggi, per mostrare i cambiamenti della società, dell’economia e così creare un grande archivio storico». Una traccia significativa dei mutamenti sociali negli ultimi decenni sta già nell’archivio di Ferrara. Che nota differenze sostanziali tra ieri e oggi: «Ho sempre usato la fotografia in senso culturale e politico – dice – e oggi avverto prima di tutto è il disincanto, la disillusione, il disinteresse nei confronti della politica militante. La partecipazione attiva è azzerata – insiste il fotografo – e i pochi che si impegnano sono considerati un fastidio. Un’idea triste che s’è andata affermando in un processo che è iniziato da vent’anni e che ha certamente tra i responsabili la televisione e il mondo dell’informazione».
Non è un pessimista Luciano Ferrara: «Non tutto è perso – riprende il suo ragionamento – al Sud c’è un grande fermento e bisogna ripartire presto. Dalle piccole cose, dalle istanze delle minoranze, dai bisogni». Ovviamente facendo conti con i cambiamenti per «capire quali sono i nuovi bisogni e indagare il modo migliore per affrontarli ».
C’è poi un’altra grande questione: il racconto del Sud di oggi. «La grande stampa usa il suo format, racconta la sua storia – accusa – mentre chi indaga davvero sul territorio spesso ha soltanto internet». Conta certamente, in questa analisi, «l’indirizzo assunto dall’industria culturale e gli assetti proprietari, contano i mezzi a disposizione, ma forse conta anche che è cambiato l’approccio degli artisti, degli intellettuali che fino agli anni Ottanta hanno raccontato bene il Sud e che adesso invece segnano il passo». Fa un esempio: «A teatro dopo Mario Martone e il suo Tango glaciale del 1982 che cosa c’è stato?». Non vuole mancare di rispetto a nessuno, sottolinea Ferrara. Semplicemente gli preme dire che «oggi siamo un po’ fermi». Mancano le idee, gli intellettuali («che hanno il compito di promuovere cose nuove», precisa) sono silenti «ed è cambiato anche lo spirito: una volta pur di fare un lavoro ci si impegnava le auto. Adesso questa cosa non la farebbe più nessuno». C’è anche un ruolo negativo svolto dalla politica, che costringe «i migliori a partire» e spesso chi va via non mantiene «un filo politico e culturale con il territorio di provenienza». Il risultato è che oggi «si fa cultura davvero a Londra o a Berlino: è lì che si racconta non qui». Questa idea del racconto, questo spirito dell’innovazione, la sperimentazione nel «laboratorio stradale». Tutto questo manca. Una mano può darla il Forum della cultura del 2013, l’altra bisogna darsela da soli. Ferrara ha aperto il suo studio fotografico alla nuova generazione di fotografi napoletani. «Credo sia giusto mettere a disposizione la mia esperienza. Per far imparare il mestiere, certo. Ma anche per insegnare a campare con la fotografia. Che altrimenti fare belle foto non serve a niente». Commenta soddisfatto: «I frutti che stiamo raccogliendo sono davvero buoni». Concreta arte partenopea.
BOX MUSEO MADRE
«La verità di Napoli è destinata per ragioni addirittura antropologiche ad apparire come qualcosa di straordinario, nel bene e nel male. E la fotografia sembra in grado di registrare meglio e più di altri linguaggi creativi ciò che tutti i visitatori sanno per esperienza, e cioè che in questa città accade molto spesso il miracolo di incontrare una realtà che, se arriva alla verità, è sempre per eccesso». Si presenta con questo incipit la mostra “‘O vero”, una collettiva di venti fotografi napoletani allestita al museo Madre di Napoli (www.museomadre.it) a cui partecipa anche il fotoreporter Luciano Ferrara. Racconta: «È la prima volta che una mostra fotografica entra in questo museo – sottolinea – siamo molto felici di esserci. E di raccontare con le immagini le trasformazioni di Napoli». Un grande risultato: «Va detta una cosa però: la fotografia purtroppo è quella che svela i problemi. Ci hanno chiamati – insiste – solo quando non c’erano più soldi. È giusto esserci, sostenere il progetto e dare il proprio contributo. Ma la fotografia va rispettata di più».