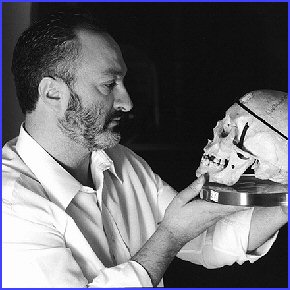Il bellissimo sito di informazione di Reggio Calabria, Libera Reggio, mi ha chiesto un’intervista per raccontare il progetto Stopndrangheta.it e il nostro modo di fare antimafia. Se vi interessa, leggete qui.
Category Archives: Interviste
Giorgio Bocca: i miei viaggi in Calabria sulle tracce di Valarioti
Di reportage al Sud Giorgio Bocca è un vero esperto. «Ne avrò fatti venti di viaggi al Sud», dice. Tutti i giornali («a parte la Gazzetta del Popolo», precisa) lo hanno «mandato giù, sin dagli anni Cinquanta: all’Europeo uno dei primi servizi era su un giovanotto che aveva rapito una ragazza per sposarla. Veniva fuori – sottolinea – questo strano mondo in cui vigevano regole di un gioco barbaro». Da allora ha sempre continuato a fare il suo lavoro di giornalista «ponendomi la stessa domanda: perché quando in Italia si fa un passo avanti, qui se ne fanno due indietro?». Non ha una risposta, neppure oggi. È sincero invece il suo “stupore” dovuto al fatto che «nel corso degli anni non c’è mai stata una vera differenza». Nessun miglioramento vero, «forse per alcune cose è sempre peggio». Un atto d’accusa pesante.
Tra le tante inchieste sul Sud, una viene spesso ricordata. Per la capacità di guardare nelle cose, perché è figlia di un viaggio lungo e pieno di storie incredibili, per l’analisi spietata e cruda dei fatti. Perché è finita in un fortunatissimo libro del 1992 “L’inferno – Profondo Sud, male oscuro”.
Scrive Bocca: «Visto dall’alto l’inferno degli italiani è bellissimo». E dice già molte cose, nel profondo. Nel capitolo dedicato alla Calabria (“Aspra Calabria”) racconta della Locride e dei sequestri di persona (e gli viene in mente il Vietnam), di Corrado Alvaro e San Luca, di medici legali e sbirri, di ‘ndranghetisti e avvocati. Racconta del suo incontro con il senatore poeta Emilio Argiroffi e delle imprese del ras della Dc di Taurianova Ciccio Mazzetta, della cosca Piromalli e del sequestro di Paul Getty jr, del giudice Cordova e dell’omicidio dell’ex presidente delle Ferrovie dello Stato Vico Ligato («era un ladro»), delle leggende e dei segni della Magna Grecia, dello storico Gaetano Cingari («era molto bravo, ricordo una sera a cena a casa sua che si vedeva il mare», dice) e di Giacomo Mancini («un politico che mi piaceva perché era un uomo coraggioso e deciso, nella politica contava», osserva). Racconta anche di Rosarno, della morte di Peppe Valarioti e della battaglia di Peppino Lavorato.
Dell’inferno del Sud, della Calabria, Bocca ascolta i suoni e respira gli odori, attraversa le viscere. E non può non chiedersi ancora oggi, a distanza di quasi vent’anni, «per quale peccato originale, per quali orgogli, per quale maledizione della storia, per quale fatalità geografica noi italiani del nord e del sud non riusciamo a fare di questo Paese un paese unito?».
Di questo siamo andati a discutere con Giorgio Bocca quando abbiamo deciso di scrivere questo libro. La sua casa di Milano sta in centro, a due passi dal Cenacolo di Leonardo. Ci riceve nel suo studio, una stanza vissuta in maniera creativa, quasi fosse quella di un adolescente. Sta dietro la sua scrivania – enorme, piena di giornali – e risponde con calma e passione alle domande. Fa spesso riferimento al passato, alla memoria, alla storia. E il fatto che siamo in una stanza che ospita in maniera ordinata per argomento migliaia e migliaia di libri – neanche fosse una biblioteca pubblica – rende tutto più credibile e avvolgente. È una leggenda del giornalismo, ma accetta di parlare e di mettersi in discussione per un piccolo libro. Si schermisce subito, non si considera la persona più adatta a parlare del Sud. Spiega: «Sono un po’ prevenuto: mio nonno era un sergente savoiardo che dava la caccia ai briganti», ride fragorosamente. «Povero diavolo – aggiunge – non capiva cosa facevano». Poi il discorso di fa subito serio. Bocca riflette ad alta voce, cerca una soluzione. Parla del Sud, ma si riferisce all’Italia di oggi. Che non gli piace, come sa bene chi legge la sua rubrica settimanale sull’Espresso. Che considera in pericolo, che quasi gli fa paura.
Si chiede spesso, ammette, «il perché nel meridione d’Italia ci sono mali così radicati», perché dalle nostre parti ci sono problemi che non si trovano in zone simili alle nostre: «non li trovi né in Grecia, né in Spagna». Analizza: «Ogni volta che uno fa un’indagine trova i colpevoli: di solito si cerca una risposta politica, si parla del capitalismo, per esempio, magari della destra. Poi però a una riflessione un po’ più profonda emerge chiaramente che la risposta è insufficiente: non si riesce mai a trovare un riparo definitivo, la vera peculiarità dei guai del meridione». La stampa non affronta i temi fino in fondo perché «è difficile e pericoloso affrontarle. I corrispondenti locali sono tutti condizionati e hanno paura che gli sparino. La letteratura s’è occupata tantissimo del Sud, la questione meridionale è stata studiata molto, ma nessuno si è occupato di capire la ragione vera» di questo arretramento. In questa indeterminatezza, Giorgio Bocca ha una certezza: «La radice è storica. Ma non riesco a capire quale è, perché ci sia questa perseveranza nel male», perché in Italia «c’è il Sud peggiore del Mediterraneo». È una domanda alla quale neppure «i meridionalisti danno una risposta».
Va a ritroso nei secoli, esclude che le colpe possano essere addebitate al periodo della Magna Grecia – «il periodo aureo», lo definisce. «Ho visitato il museo di Reggio in uno dei rari periodi in cui era aperto. Certe cose erano davvero bellissime», aggiunge – ha qualche dubbio sulla dominazione spagnola e rileva che «bisognerebbe studiare il periodo di occupazione degli arabi, che è stato importantissimo e secondo me ha avuto un effetto negativo».
Racconta di essere stato recentemente sulla costiera amalfitana e a Napoli: «L’immondizia lasciata per strada… è soltanto la camorra che vuole usare questa cosa per seppellire i rifiuti tossici o è anche la gente che se ne frega? È un mistero per me il perché questa città debba essere così autolesionista».
Giorgio Bocca ne parla, ma si capisce che in fondo non l’accetta. Merito della sua passione civile, colpa del fatto di essere stato un protagonista della Resistenza. «Tutto nasce dal fatto che avendo fatto la guerra partigiana mi ero illuso che la Resistenza e l’antifascismo fossero capaci di rigenerare l’Italia, di farla diventare un paese civile». La guerra partigiana, racconta, «è stato un periodo meraviglioso. Si aveva l’impressione che finalmente gli italiani fossero cambiati. In un periodo di grandi difficoltà – insiste – trovavi la gente che rischiava la vita per aiutarti. Arrivavi a casa dei contadini e ti ospitavano anche se c’era il cartello tedesco che li minacciava di bruciare loro la casa. La Resistenza è stata possibile – chiarisce – perché lo Stato sociale permetteva che ci fosse. Da noi le fabbriche, gli industriali, tutti collaboravano con la Resistenza. Ci davano soldi, divise, scarpe. Anche la Chiesa: i vescovi erano filofascisti, ma i parroci di campagna erano tutti partigiani». E invece oggi gli italiani «sono tornati peggio di prima. Mi sono accorto di una triste verità facendo il mio mestiere: nonostante il sacrificio di operai, sindacalisti e contadini, che sono stati molto coraggiosi, in Italia prevale sempre il peggio». E insiste: «Capisco che i giovani oggi facciano dei giornali coraggiosi o trasmissioni tv di denuncia, ma uno come me è ormai rassegnato al peggio. Forse bisogna rendersi conto che gli uomini sono fatti così, che sono brutte bestie». Tutte le volte «che lo dico me ne pento. La rassegnazione è sbagliata, mi dico che cambierà. Ma dopo cinquant’anni è sempre la stessa storia». Insiste, rincara la dose: «Non c’è niente da fare». Solo il caso, «che nella storia gioca un ruolo importantissimo, ci tirerà fuori da questa situazione. Casualmente come siamo entrati in questo vortice negativo per caso ne usciremo in qualche modo».
È lo stato d’animo di un uomo che ha combattuto per la libertà e che oggi avverte che l’Italia sta tornando indietro. Bocca non vuole sottrarsi alle analisi invocando un facile pessimismo, piuttosto partendo dal Sud e dai suoi problemi vuole parlare di come sta oggi l’Italia. Pronuncia una frase che, pur nella sua semplicità, fa male come poche: «È triste venire al sud. È costante l’umiliazione degli onesti». Un pugno nello stomaco. Parla degli intellettuali meridionale che vivono una condizione «molto difficile», ma osserva che in fondo a causa di Berlusconi «stiamo sperimentando che anche al nord viviamo tutti in una società autoritaria e arretrata». Berlusconi è riuscito a «mettere in condizioni umilianti le persone. In questo senso le differenze tra nord e sud sono diminuite. La borghesia del nord bada solo ai soldi e ai furti: la mancanza di etica è comune a tutto il Paese». Ha giudizi tranchant sulla politica: Casini? «Fa ridere, è l’erede democristiano peggiore». La Lega? «È una conferma che gli italiani sono antidemocratici e arretrati». Aggiunge lui che per primo scoprì in Italia il fenomeno di Bossi e delle camicie verdi: «È un periodo in cui il razzismo è forte. Siamo al fascismo puro. Quando ho scelto il titolo della mia rubrica sull’Espresso, l’Antitaliano – racconta – avevo capito che gli italiani avevano una voglia matta di tornare al fascismo. Purtroppo non imparano mai». Insiste, fino allo sfinimento: «La libertà l’abbiamo consegnata a Berlusconi. Anche la Resistenza, anche il Risorgimento». Si infervora: «Berlusconi è peggio del fascismo. Il fascismo è stato un movimento della piccola e media borghesia contro l’alta borghesia liberale. Mussolini era una persona intelligente. Qua siamo al qualunquismo più schifoso. C’è stata una marcia indietro». Spiega: «Penso che arriveremo presto anche allo squadrismo e alla minacce fisiche. Adesso stanno facendo campagna per abolire le voci contrarie in televisione. Un giorno o l’altro verranno a casa mia a cercare di picchiarmi. Come ha fatto il fascismo. Prendi un po’ di persone influenti e le ammazzi e cala il silenzio. Fino a qualche tempo fa – osserva Bocca come un fiume in piena – se mi avessero chiesto se era possibile il ritorno al fascismo avrei detto no. Adesso comincio ad avere paura». Ammette di aver paura anche per il suo giornale, la Repubblica: «Anche i liberali sono passati al fascismo, se De Benedetti viene messo alle corde che succede?», si domanda. Quel che è certo, secondo Bocca, è che già adesso ci sono «enormi condizionamenti della democrazia».
Un ragionamento che lo fa tornare indietro negli anni, quando «facevamo del buon giornalismo». Un atto di accusa, forse, alla politica e alla società di oggi. «Abbiamo fatto un buon giornalismo perché avevamo alle spalle il movimento operaio e i comunisti. Il Pci che è stato ad alcuni considerato, e a ragione, stalinista. Però quando arrivavo in una città, andavo alla sede del Pci e mi raccontavano cosa succedeva nell’economia. E se venivo attaccato dai fascisti, la sinistra mi difendeva. Il sindacato contadino e operaio funzionava bene ma è stato fatto fuori. Adesso c’è la sensazione di essere completamente indifeso. Quello che diceva il generale Dalla Chiesa: quando sei isolato ti possono anche far fuori. Quando hai l’opinione pubblica alla spalle ti protegge, altrimenti.. E se eliminano alcuni dirigenti della sinistra, l’unanimismo diventa un regime». Di qui la necessità di guardare indietro, di ripensare al passato: «Tutto quello che dico è memoria».
Parla anche di mafia, fuori dagli schemi: «Con il tempo mi sono fatto la convinzione che le mafie sono parte costituente della politica italiana, perché credo che ci sia la necessità che esistano. Organizzano in senso negativo questa anarchia italiana, il consenso, la voglia di anarchia, la disciplinano». Parole pesanti. E ancora: «Il mio governo è mafioso, non puoi chiedere al governo di fare una politica antimafia se è d’accordo con la mafia. Michele Greco – sottolinea – aveva una tenuta di caccia in cui andava a sparare fagiani anche il colonnello dei carabinieri. La moglie di Totò Riina ha partorito tre volte nell’ospedale di Palermo e il primario sapeva benissimo dove stava. Le mafie fanno parte costituente dello Stato italiano. Se non si capisce questo…».
Se parli con Giorgio Bocca approfitti e ti fai raccontare qualcosa della sua carriera di giornalista: «La mia carriera di giornalista? Se non c’è il caso che ti aiuta… Ero in un giornale monarchico, facevo una vita da cani e avevo un direttore di estrema destra». Poi il caso. «A dirigere l’Europeo a Milano arriva un certo Michele Serra: mi manda a chiamare e la mia vita cambia». E si ritrova a lavorare con Cederna, Fallaci, Trevisani: «Era pieno di gente in gamba». Il giornale a cui è più legato «è stato Il Giorno perché lì avevo alle spalle, un periodo molto privilegiato, l’Eni e quindi una disponibilità di soldi enorme: facevamo un giornale bellissimo, siamo stati i primi a fare i colori, le sezioni per i bambini e la moda». Poi è stato il tempo di Repubblica «che è stato un giornale con un grande direttore come Scalfari: uno che sapeva dirigere bene l’orchestra». Non è stato direttore Bocca. «No», dice. E svela un piccolo e divertente retroscena: «Un giorno durante la Resistenza comandai un’azione: dopo una lunghissima marcia per arrivare su un presidio tedesco, facemmo un’imboscata, poi tornai nella valle. Credevo che avrei avuto l’approvazione dei miei comandanti e invece la sera a cena li sentii parlare – io ero nella stanza accanto – e dicevano: quello stronzo di Bocca ha sbagliato tutto!». Ride di gusto: «Allora ho detto basta, ho capito che comandare non fa per me».
Avrebbe «voglia di fare un altro viaggio al Sud, ma alla mia età viaggiare diventa impossibile, nella vecchiaia ci sono limiti fisici con cui fare i conti». Spiega: «In quel viaggio in Calabria sull’Aspromonte ho camminato per delle ore e poi… avevo più coraggio. Quando si è giovani si crede di essere immortali. Oggi dei servizi così non sarei in grado di farli». Poi la lezione: «Il giornalismo? Guardare e raccontare. Se uno non è un cretino, la verità la vede subito. Non è difficile capire quello che succede. Si capisce benissimo dove comanda la mafia, dove i politici rubano». Di questo ci sarebbe bisogno.
(intervista realizzata nell’autunno 2009 e pubblicata su “Il caso Valarioti, giugno 2010)
Giuseppe Smorto: pezzi di Paese dati per persi
Pensiamo che esista in Italia un doppio problema: quello della rappresentazione del sud e quello dell’autorappresentazione. A noi paiono del tutto insufficienti. È d’accordo?
A casa mia si leggeva Il Giorno. Lo dico per sottolineare che è passata un’epoca e che c’era un tempo in cui al sud andavano i grandi inviati. Proprio nelle ultime settimane nella sua rubrica sull’Espresso Giorgio Bocca ha ricordato alcune vicende calabresi raccontate nei suoi viaggi.Oggi è diverso.
Senza nulla togliere agli inviati di oggi, alcuni dei quali sono molto bravi, ho l’impressione che ai tempi del grande giornalismo su carta ci fosse un maggiore investimento sul sud da parte dei grandi giornali.
Perché accadeva?
Era come se ritenessero il sud ancora una questione aperta, risolvibile. Oggi invece s’è creato un effetto di abbandono e rassegnazione che va in direzione doppia. Oggi è come se il sud, o almeno certe zone del sud, nei grandi giornali venisse considerato un problema non risolvibile a breve termine. Questo, probabilmente, ha come conseguenza una più scarsa attenzione e un investimento giornalistico minore. Ma questo non accade solo per i giornali. Recentemente ho letto il libro di un magistrato che era stato in servizio a Locri: il ragionamento mi pare sempre lo stesso e riguarda il fatto che la Calabria è bella, la gente splendida ma poi bisogna andare via perché dalle nostre parti non si può combinare nulla di buono. Anche questa è rassegnazione. E in effetti la situazione è difficilissima: la procura di Reggio Calabria sotto attacco, Rosarno, il territorio ― checché se ne dica ― completamente controllato, la scarsità o forse dovrei dire assenza delle denunce. Poi succedono delle cose e la situazione cambia.
Spiegati.
In un periodo come il nostro in cui interi territori vengono considerati completamente consegnati alla criminalità succede che c’è uno scrittore che si chiama Roberto Saviano e cambia lo stato dei fatti.
Alla Calabria manca Saviano?
No, non è la risposta da dare. Però osservo che quando l’informazione riesce a trovare le forme ― anche artistiche ― di
raccontare un territorio alla fine la situazione cambia, i risultati cominciano a esserci e i casalesi vengono condannati. In questo caso, c’è stato un investimento dell’informazione: s’è parlato più di casalesi che di ‘ndrangheta, eppure sappiamo benissimo che la ‘ndrangheta è al momento l’organizzazione criminale più forte. Nelle scorse settimane Saviano ha scritto un articolo-provocazione in cui sostiene che dobbiamo essere tutti osservatori del voto sul modello di quelli Onu. La cosa viene presa come una boutade, eppure se si va in tantissimi paesi della Calabria o della Campania di osservatori ce ne sarebbe un gran bisogno. La verità è che fa paura in Italia dire che ci sono zone come l’Afghanistan. Insomma, alla Calabria manca il modo di finire in prima pagina con le idee.
I grandi giornali si sono fatti guidare da Saviano, eppure
avrebbero la forza e l’autorevolezza di fare da sé.
L’informazione non è pedagogica, è lo specchio del Paese e racconta quello che la gente vuole leggere. E poi è molto difficile mettere in pagina la tragica normalità dei fatti che, dopo il secondo o il terzo giorno, non interessa più nessuno.
Il tuo giornale o un altro grande giornale però potrebbero decidere di lanciare una grande campagna sul sud o la Calabria.Le statistiche che abbiamo a disposizione ci dicono che quelli sono i posti di cui i nostri giornali si occupano di più.
Certo, si potrebbe fare sempre meglio, ma non potrebbe essere una battaglia quotidiana. Ci sono delle difficoltà e delle carenze però. Oggi innanzitutto c’è molta meno cronaca ― i giornali sono stati sostituiti da internet ― per cui o si fanno dei grandi approfondimenti, come è stato per esempio su Rosarno, o fatalmente non ne parli. Oggi a volte si preferisce mandare gli inviati in Colombia senza pensare che in certi momenti la Colombia ce l’abbiamo alle porte di casa. E poi forse bisogna guardare a cosa è accaduto a Palermo.
Siamo più avanti a Palermo.
Forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo, ma nei fatti a Palermo la mafia è in totale disfacimento: resta un solo capo e l’organizzazione è allo sbando tanto da non riuscire neppure a chiedere il pizzo.
A Palermo c’è tanta gente che ci mette la faccia. È un processo più avanzato, in Calabria non succede ancora, la situazione è molto diversa. Ma credo che ogni tanto si dovrebbe parlare delle esperienze positive e magari non considerare la situazione come irrisolvibile.
Ma sono solo i grandi media a considerare “persi” certi pezzi d’Italia o si tratta di una convinzione che appartiene
all’intera classe dirigente?
Secondo me è la stessa cosa. I grandi giornali riassumono posizioni che stanno nella classe dirigente, che vivono nell’opinione pubblica. «Certo che gli aborigeni li avete trattati davvero molto male». E lui risponde: «E voi gli zingari come li avete trattati?» Non sono più un’emergenza i rom, ci sembra normale ormai che i bambini stiano per strada, che esistano quei campi. Allo stesso modo sembra normale a tutti che la Calabria viva questa condizione.
Appare normale anche ai calabresi.
Il titolo di codice è “rassegnazione”. È così da parte dei giornali che ritengono quel territorio senza possibilità di miglioramento a breve periodo e non prendono in considerazione quello che è accaduto con la mafia. Ma c’è rassegnazione anche tra i cittadini calabresi, divisi tra quelli che godono di questa situazione di arretratezza e assistenzialismo (senza magari essere collusi) e quelli che stanno male ma sono convinti che nulla possa cambiare, che non ce n’è la forza. Tutto questo conviene anche a chi controlla il territorio. C’è anche un problema sociale: nel momento in cui si disgrega il tessuto del lavoro, faciliti il lavoro dei clan. Più licenzi, meno lavoro offri e più braccia fornisci alla criminalità organizzata. Basti pensare alla trasformazione subìta da Crotone: era una grandissima realtà operaia e contadina con un tessuto democratico importante e anche lei è finita in mano alla ‘ndrangheta con famiglie che riescono a eleggere persino un senatore in Germania.
Sono diverse le questioni in campo.
All’inizio di gennaio ho posto la questione durante una riunione del giornale. Ho detto: c’è stato l’attentato alla procura di Reggio Calabria, a due passi c’è la Piana dove è scoppiato il caso Rosarno e dall’altra parte la Locride. È una cosa normale che una zona così vasta di territorio ― dove peraltro vogliono costruire il ponte ― viva questa emergenza? Abbiamo parlato molto di Reggio in quelle settimane. Lo ripeto: i giornali potrebbero avere un ruolo e, secondo me, in determinati periodi ce l’hanno. Ma è lo Stato a dover essere più presente per prima cosa, non i giornali.
Nessun grande giornale ha una redazione in Calabria.
Questo è un problema.C’è un motivo per cui tutti i giornali non hanno una redazione in Calabria. Stiamo parlando di un territorio economicamente depresso e se non hai una base di possibili inserzionisti non apri. E c’è anche la complicazione che devi stare molto attento agli inserzionisti, a che soldi arrivano. Peraltro stiamo parlando di un mondo in crisi in cui i giornali non aprono più redazioni locali. Comunque l’impressione è che ― storicamente ― l’investimento informativo sul sud sia minore che in passato.
In questo può aiutare il web?
Il web può essere utile per tutti i luoghi che non appaiono nella grande informazione: può dare visibilità se lo fai bene e in modo serio.
Per la Calabria probabilmente l’omicidio di Peppe Valarioti e Giannino Losardo hanno segnato una cesura. E anche la memoria di quelle storie si sgretola.
Accade che alcune storie siano valorizzate di più e altre meno. Accade che le cose ― anche le morti ― in certi posti siano considerate più normali che altrove. E poi trent’anni fa soprattutto c’erano un altro sindacato e un altro partito, i fatti di Reggio erano ancora caldi. Diciamo che si può arrivare tranquillamente alla conclusione che, in qualche modo, tutti hanno abbandonato quel territorio: l’informazione, la politica.
La politica.
Beh, quale politico abbiamo espresso negli ultimi anni, quanta Calabria i politici hanno portato all’attenzione del Paese? Non mi pare affatto che la Calabria abbia prodotto una classe politica di grande livello.
In effetti no. La Calabria però produce tantissimi emigranti di grande qualità e successo.
È vero. E si dovrebbe trovare una modalità per valorizzare tutte le intelligenze che stanno in Calabria o fuori dalla Calabria in nome del futuro del territorio. Bisogna trovare il modo di valorizzare la nostra cultura del saper fare le cose. Chi lo fa? Difficile da realizzare, ma trovo affascinante l’idea di far ragionare il meglio che la Calabria ha prodotto su cinque o dieci grandi progetti concreti.
E questo fa parte dell’autorappresentazione. Riguarda il modo di esprimersi e raccontarsi della Calabria. Corrado
Alvaro a parte, se pensi alla Calabria che artisti ti vengono in mente?
Ai giornalisti più giovani dico sempre: leggete Corrado Alvaro se volete capire come si scrive in italiano… Mi viene in mente Carmine Abate che penso sia un grandissimo scrittore anche se forse per troppe volte ha raccontato dei calabro-albanesi, poi Mimmo Gangemi. A lui vorrei chiedere: perché hai iniziato a scrivere solo dopo la pensione? E di registi Calopresti, Amelio. Però confesso che l’unico film bello sulla Calabria è “Un ragazzo di Calabria”. L’ho rivisto recentemente e mi sono commosso quando il ragazzo protagonista ha vinto i giochi della gioventù. Oggi quel film non glielo farebbero nemmeno fare…
(tratta da “Il caso Valarioti”)
Giuseppe Gagliardi, regista che racconta Tatanka
Il regista calabrese Giuseppe Gagliardi ha un film in uscita “Tatanka scatenato”, ispirato a un racconto di Roberto Saviano. È lui il sesto protagonista di “Creatività meridiane”, il ciclo di incontri di Danilo Chirico con intellettuali, artisti, politici, semplici cittadini meridionali che hanno piccole e grandi esperienze da raccontare alla ricerca di nuove idee, memorie disperse e buone pratiche. “Creatività meridiane” è un tentativo di fare un racconto autentico del Mezzogiorno, un modo di provare a scrivere parole inedite sul Sud, un contributo a un ragionamento – collettivo e individuale – sempre più urgente: ricostruire un’originale identità meridionale. In un Paese davvero unito.
 «Il Sud è il luogo che se tutto funzionasse sarebbe un paradiso». Alla domanda su cos’è oggi il Sud, non esita neppure un attimo. Aggiunge un attimo dopo: «Il problema è il fatto che non funziona quasi nulla». Giuseppe Gagliardi ha 33 anni, è un regista e sceneggiatore calabrese. Che vive altrove, come molti suoi coetanei, come molti che hanno deciso di fare cinema («in Calabria sarebbe impossibile», precisa).
«Il Sud è il luogo che se tutto funzionasse sarebbe un paradiso». Alla domanda su cos’è oggi il Sud, non esita neppure un attimo. Aggiunge un attimo dopo: «Il problema è il fatto che non funziona quasi nulla». Giuseppe Gagliardi ha 33 anni, è un regista e sceneggiatore calabrese. Che vive altrove, come molti suoi coetanei, come molti che hanno deciso di fare cinema («in Calabria sarebbe impossibile», precisa).
«Potenzialmente – sottolinea – al Sud ci potrebbe essere tutto». E invece «da 150 anni questo pezzo d’Italia è rimasto schiacciato da dinamiche politiche inquietanti: nel processo di unificazione c’è stata la volontà storica di ridurlo così, la volontà precisa di trasformarlo in un luogo in cui tutto va in malora. Nella periferia dell’impero». Una realtà «che fa male, ma che è così». Che va spiegata, «raccontata», dice. E il riferimento non può che essere al fortunatissimo libro di Pino Aprile, “Terroni”.
Non tutto dipende dagli altri, però. Anche i meridionali, i calabresi devono fare la propria parte. Da questo punto di vista Giuseppe Gagliardi introduce una punta di ottimismo attraverso un elemento generazionale: «C’è un dato interessante in Calabria nell’ultimo periodo: un dato anagrafico. Ha preso il potere un gruppo di quarantenni, finalmente una generazione che sa cos’è una email, Skype o un motore di ricerca». Gagliardi si riferisce al nuovo presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti (classe ’66) e ai suoi più stretti collaboratori (peraltro da lui indicati, la vicepresidente Antonella Stasi, anche lei del ’66, l’assessore al Bilancio Giacomo Mancini che ha 37 anni). Una cosa significativa, per il regista cosentino, che naturalmente dovrà «essere supportata dai fatti sui quali dare il nostro giudizio politico».
È importante, fondamentale il ruolo della classe dirigente di un territorio, la capacità di cogliere i cambiamenti, di capire i processi, di instaurare un rapporto chiaro e utile con i cittadini. Per spiegarlo il regista ricorre a un’esperienza personale: Saracinema. È un festival cinematografico pensato e organizzato da Gagliardi per Saracena, un incantevole borgo (a rischio abbandono) che sta in provincia di Cosenza, a metà strada tra il Pollino e il mar Tirreno. È il 2006 quando nasce questa esperienza, che ha almeno due importanti caratteristiche: la prima è che il cinema sta dentro il paese, lo attraversa, lo trasforma in una grande sala, in una grande casa di produzione, in una grande platea, in un luogo pieno di osterie, suoni e immagini. L’altra è che il festival offre a trenta giovani (calabresi e non) l’occasione di incontrare faccia a faccia registi, autori e produttori altrimenti difficili da incrociare. Un’idea affascinante e concreta. Una buona pratica, soprattutto per un territorio che ancora non ha un vero festival del cinema. «In tre anni Saracinema era cresciuto, era diventato una bella realtà – sottolinea – Poi ci siamo scontrati con la realtà, con la politica che ha deciso di non seguirlo più, di non sostenerlo. E dopo alcuni anni di grandi sacrifici siamo stati costretti a lasciare stare». Occasione mancata, l’ennesima per la Calabria. Una situazione paradigmatica per la regione in punta allo Stivale che probabilmente è alla base di uno degli elementi più tristi: «l’esodo continuo, da oltre 50 anni, di tutti i cervelli più interessanti della regione. Costretti ad andare via, e che trovano le loro occasioni migliori lontano da casa». Attacca Giuseppe Gagliardi: «È questo il risultato di un sistema fatto di assistenzialismo e clientelismo». E invece no, invece «i cittadini devono avere l’opportunità di realizzare i loro progetti. Se questo accade, possono succedere cose interessanti».
 Gagliardi è un calabrese che fa cinema, ma non fa cinema in Calabria. «Fino a oggi non è stato possibile realizzare un film, anche se mi piacerebbe molto», sottolinea. Così un regista che viene premiato al festival di Nanni Moretti con il Sacher d’argento (nel 2003 con il corto Peperoni), che riceve un premio al Torino Film Festival (con il documentario musicale Doichlanda, ancora nel 2003), che con il suo primo lungometraggio “La vera storia di Tony Vilar” partecipa a festival come quello di Roma (nel 2006) e il prestigiosissimo Tribeca di New York (nel 2007) alla fine si trova a constatare che «continua a valere il detto “nemo propheta in patria”», che il cinema per la Calabria è un poco più di un ufo. Eppure la storia di Tony Vilar, l’emigrante calabrese Antonio Ragusa partito nel 1952 alla volta dell’Argentina e diventano famoso in tutto il mondo con il brano “Quanto calienta el sol”, era un film «legato alla riscoperta di una certa calabresità, una certa italianità tra Buenos Aires e New York». Anche questo progetto «non ha mai avuto un sostegno reale», commenta.
Gagliardi è un calabrese che fa cinema, ma non fa cinema in Calabria. «Fino a oggi non è stato possibile realizzare un film, anche se mi piacerebbe molto», sottolinea. Così un regista che viene premiato al festival di Nanni Moretti con il Sacher d’argento (nel 2003 con il corto Peperoni), che riceve un premio al Torino Film Festival (con il documentario musicale Doichlanda, ancora nel 2003), che con il suo primo lungometraggio “La vera storia di Tony Vilar” partecipa a festival come quello di Roma (nel 2006) e il prestigiosissimo Tribeca di New York (nel 2007) alla fine si trova a constatare che «continua a valere il detto “nemo propheta in patria”», che il cinema per la Calabria è un poco più di un ufo. Eppure la storia di Tony Vilar, l’emigrante calabrese Antonio Ragusa partito nel 1952 alla volta dell’Argentina e diventano famoso in tutto il mondo con il brano “Quanto calienta el sol”, era un film «legato alla riscoperta di una certa calabresità, una certa italianità tra Buenos Aires e New York». Anche questo progetto «non ha mai avuto un sostegno reale», commenta.
Quello che non si capisce in Calabria, secondo Gagliardi, è che anche «la cultura è un’industria»: il prodotto artistico e culturale «va inteso come qualcosa da mettere a disposizione per fare crescere il territorio». Altre regioni lo hanno capito: «In tutti i posti è difficile fare il cinema, ma alcune cose interessanti altrove cominciano a muoversi», dalla Puglia fino alla Basilicata.
 La verità è che «dove una cosa funziona, per riflesso funzionano anche le altre», chiarisce. E spiega: «Se in Salento funziona il turismo, anche il resto va bene. Ora – aggiunge – spero che in Calabria la nuova film commission faccia delle cose buone e utili al cinema e al territorio». È un problema di scelte politiche e imprenditoriali, «è un problema di spazi, di luoghi, di opportunità dove poter esprimere e fare crescere le creatività». Se ci fossero gli spazi, insiste, «centinaia di ragazzi avrebbero la possibilità di fare il cinema. Ci dovrebbe essere un supporto concreto, almeno nella diffusione».
La verità è che «dove una cosa funziona, per riflesso funzionano anche le altre», chiarisce. E spiega: «Se in Salento funziona il turismo, anche il resto va bene. Ora – aggiunge – spero che in Calabria la nuova film commission faccia delle cose buone e utili al cinema e al territorio». È un problema di scelte politiche e imprenditoriali, «è un problema di spazi, di luoghi, di opportunità dove poter esprimere e fare crescere le creatività». Se ci fossero gli spazi, insiste, «centinaia di ragazzi avrebbero la possibilità di fare il cinema. Ci dovrebbe essere un supporto concreto, almeno nella diffusione».
Probabilmente è proprio per questa serie di ragioni che la Calabria «è raccontata poco e male – aggiunge il regista – mi pare che sia l’unica regione, insieme al Molise, che non ha nessun tipo di letteratura scritta, visiva o cantata. Forse è dovuto anche al fatto che in Calabria c’è una sorta di esterofilia che non riesce ad apprezzare quello che ha». Ma c’è di più, e ritorna il ruolo della classe dirigente: «Ogni anno ci sono 25mila premi organizzati a beneficio dei calabresi nel mondo o robe di questo tipo, che servono a organizzare serate per politici e vescovi e a nient’altro», attacca. Nessuna programmazione, nessuna idea. «Invece – rimarca – con gli stessi soldi si potrebbero fare cose molto concrete per far crescere professionalità artistiche e culturali». Ecco perché «purtroppo non c’è uno scrittore di riferimento che non sia defunto, non c’è un cinema preciso, non c’è una band». Un esempio? «Peppe Voltarelli ha vinto il premio Tenco come miglior album in dialetto. Chi lo sa in Calabria? chi vuole valorizzare questa esperienza?».
 È anche per questo che Gagliardi ha deciso di girare il suo nuovo film in Campania, a partire da un racconto scritto da Roberto Saviano. Il film si intitola “Tatanka scatenato”, racconta – senza stereotipi – una storia di un riscatto di un gruppo di giovani di Marcianise, in provincia di Caserta. Un gruppo di giovani uniti dal sangue e dal sudore del pugilato, che hanno nel vicecampione olimpico Clemente Russo il loro rappresentante più famoso. «È stata un’esperienza molto forte, interessante – racconta Gagliardi – Un film , girato tra la Campania e Berlino che ha un tono neorealista, girato con molte parti in dialetto, con buona parte degli attori presi dalla strada. È stato interessante conoscere e sviscerare le dinamiche sociali del Sud». L’uscita in sala è prevista per marzo, con 200 copie. Un ottimo numero. «Siamo molto contenti perché sono numeri significativi rispetto a quello che accade in questo momento nel cinema italiano». Una grande opportunità. «Abbiamo fatto una proiezione privata con Roberto Saviano: il film gli è molto piaciuto, spero che ci dia una mano a promuoverlo». L’occasione di fare il salto di qualità, magari in attesa di fare un film in Calabria «perché bisogna parlare di quello che si sa». Nel frattempo, con determinazione, continuare il proprio percorso. Da calabrese che fa cinema: «La cosa bella è che il bagaglio culturale, di ironia, di apertura sono cose che ti porti dietro. Sempre, che puoi esprimerlo nelle tue cose». Dovunque tu sia.
È anche per questo che Gagliardi ha deciso di girare il suo nuovo film in Campania, a partire da un racconto scritto da Roberto Saviano. Il film si intitola “Tatanka scatenato”, racconta – senza stereotipi – una storia di un riscatto di un gruppo di giovani di Marcianise, in provincia di Caserta. Un gruppo di giovani uniti dal sangue e dal sudore del pugilato, che hanno nel vicecampione olimpico Clemente Russo il loro rappresentante più famoso. «È stata un’esperienza molto forte, interessante – racconta Gagliardi – Un film , girato tra la Campania e Berlino che ha un tono neorealista, girato con molte parti in dialetto, con buona parte degli attori presi dalla strada. È stato interessante conoscere e sviscerare le dinamiche sociali del Sud». L’uscita in sala è prevista per marzo, con 200 copie. Un ottimo numero. «Siamo molto contenti perché sono numeri significativi rispetto a quello che accade in questo momento nel cinema italiano». Una grande opportunità. «Abbiamo fatto una proiezione privata con Roberto Saviano: il film gli è molto piaciuto, spero che ci dia una mano a promuoverlo». L’occasione di fare il salto di qualità, magari in attesa di fare un film in Calabria «perché bisogna parlare di quello che si sa». Nel frattempo, con determinazione, continuare il proprio percorso. Da calabrese che fa cinema: «La cosa bella è che il bagaglio culturale, di ironia, di apertura sono cose che ti porti dietro. Sempre, che puoi esprimerlo nelle tue cose». Dovunque tu sia.
Ulderico Pesce e i nuovi briganti
È l’attore e autore teatrale lucano Ulderico Pesce il quarto protagonista di “Creatività meridiane”, il ciclo di incontri di Danilo Chirico con intellettuali, artisti, politici, semplici cittadini meridionali che hanno piccole e grandi esperienze da raccontare alla ricerca di nuove idee, memorie disperse e buone pratiche. “Creatività meridiane” è un tentativo di fare un racconto autentico del Mezzogiorno, un modo di provare a scrivere parole inedite sul Sud, un contributo a un ragionamento – collettivo e individuale – sempre più urgente: ricostruire un’originale identità meridionale. In un Paese davvero unito.
Ha lavorato con Giorgio Albertazzi e Carmelo Bene, Luca Ronconi e Gabriele Lavia. Ne va fiero. Poi ha scelto la sua strada, quella che gli aveva indicato suo nonno che di che di mestiere faceva l’arrotino e che raccontava con un talento naturale le cose del passato. Storie vere, difficili, che lo riempivano. Quando è partito per Roma per studiare, alle pareti della sua stanza nel quartiere San Lorenzo ha appeso la foto di suo nonno. Come monito, forse. Come modello, ispirazione. È per questo che ha scelto di stare sul palcoscenico per raccontare la realtà. Di lavoratori sfruttati, di operai senza diritti, di cittadini che si ammalano. La realtà del nostro Paese, del nostro Mezzogiorno.
Ulderico Pesce è nato e vive in Basilicata. È un uomo di teatro – autore, attore e regista – che, per dirla con il grande critico del Corsera Franco Cordelli, recita come se stesse «seduto a un tavolo con ciascun spettatore». Uno che quando gli parli ti guarda negli occhi, racconta, si infervora, spiega e maledice. E non ha peli sulla lingua, nella vita come negli spettacoli. Così quando gli chiedi di partecipare al ragionamento del Domenicale di Terra sulle nuove creatività e identità meridionali, lui accetta volentieri. E dice subito: «Parlo anche da semplice cittadino». E dice subito: «Il Sud oggi è esattamente come quello di fine Ottocento: nulla è cambiato nel rapporto tra territorio, cittadini e Stato». Il paragone suona forte, ma l’attore lucano aggiunge subito: «Eravamo colonizzati dai Savoia nel 1861 e lo siamo oggi. Allora – sottolinea – lo Stato approfittò delle risorse energetiche, agricole e naturalistiche del nostro Sud lasciando la popolazione e interi pezzi di territorio sprovvisti di Stato, di quell’elemento terzo capace di assicurare giustizia e dignità, equità e diritti ai cittadini. Oggi non è diverso: lo Stato non c’è». Non si ferma qui il ragionamento di Ulderico Pesce. «Ho vissuto tutto questo sulla mia pelle – racconta – sono felice di avere una madre che è stata una bracciante agricola, ma mia madre avrebbe voluto studiare e non ha potuto. Questa è l’impronta di un’ingiustizia che hanno vissuto in tanti nel nostro territorio – insiste – e che la politica, che ha reso legale l’illegalità, non fa nulla per cambiare. Vale per la destra e per la sinistra in egual misura». Torna all’idea dello sfruttamento del Nord nei confronti del Sud, dell’abbandono dello Stato. E fa due esempi («mi piace parlare di cose concrete», dice). Il primo riguarda il Ponte sullo Stretto: «Noi meridionali non ne sentiamo il bisogno, non lo vogliamo, la nostra stessa cultura è contraria – sostiene – eppure il nostro ambiente e territorio vengono sacrificati per regalare un grosso affare a una grande impresa del Nord». E poi la Basilicata: «Bossi parla sempre di federalismo – dice – e allora parliamone con i fatti. Il nostro territorio ospita tre grandi multinazionali: l’Eni in Val d’Agri, dove estrae il 60% del fabbisogno nazionale di petrolio, la Coca Cola nel Volture, dove usa la nostra acqua, e la Fiat a Melfi». Bene, secondo Pesce, sono «tre grandi realtà che colonizzano il territorio e lo deturpano lasciando la fame alla Basilicata». Tanto che ogni anno a causa dell’emigrazione è come se sparisse «un paese di 15mila abitanti». E i lavoratori continuano a restare «senza diritti»: «Alla Fiat – attacca – ancora oggi non c’è il medico dopo le 18, come avviene in tutte le fabbriche d’Europa» e infatti «lo scorso aprile un operaio è morto per un semplice principio di infarto». Un prezzo che la Basilicata paga, senza avere nulla in cambio: «Queste tre grandi aziende le tasse le pagano altrove: parliamo di questo quando parliamo di federalismo fiscale».
 La risposta a tutto questo sta nel brigantaggio, dice Ulderico Pesce. «Sono fiero di essere nato in Basilicata, il posto in cui il fenomeno è stato più forte», rivendica. «La risposta sta in una nuova forma di brigantaggio – sottolinea – quello dei movimenti che qui al Sud sono vivi e difendono il territorio e chiedono diritti. Movimenti che devono essere autonomi dalla politica – insiste – ma che devono organizzarsi e darsi una forma per cambiarla, contaminarla», per entrarci insomma con le proprie parole d’ordine. «I movimenti sui territori devono diventare forza politica – rimarca l’attore lucano – senza leaderismi, ma senza perdere altro tempo prezioso: in questo Paese la gente perbene sta all’opposizione e deve potersi esprimere». I riferimenti vanno trovati nella letteratura e nella poesia. Rocco Scotellaro, innanzitutto. «Un poeta contadino – lo ricorda Ulderico Pesce che sul suo lavoro e della poetessa Amelia Rosselli ha anche costruito uno splendido spettacolo “Contadini del Sud” – un sindaco, un occupatore delle terre. Diciamo che è stato un politico con un’impostazione poetica e un poeta con una coscienza politica: un vero punto di riferimento». E poi Corrado Alvaro, «il Pirandello delle novelle dei primi del secolo di Ciaula scopre la luna», il poeta suicida Franco Costabile «che amo molto e che ho sentito citare ai ragazzi del movimento ambientalista di Amantea». Prova a tenere insieme tutto questo mondo Ulderico Pesce con il suo lavoro, nella scrittura e nella scena. Lo spiega in maniera appassionata: «Ho scelto di fare questo teatro per due ragioni: una artistica e una psicologica». La prima «riguarda i miei studi». Un giorno al teatro Ateneo della Sapienza a Roma Ulderico Pesce incontra Anatoli Vassilev che lo porta a Mosca. Si ferma lì più di tre anni a studiare e praticare «un teatro semplice, povero, strutturato sulla verità e sulla necessità delle emozioni», a lavorare sul Metodo Stanislavskij «secondo il quale un attore deve essere sempre vero, credibile. Tutto il contrario della tradizione artificiosa del teatro italiano». Così tra il teatro italiano «e mio nonno che faceva l’arrotino, ho scelto mio nonno e i suoi racconti. Prima li ho portati in giro in Basilicata – racconta – poi ho capito che interessavano anche a Roma o a Milano». Così ha trovato il suo linguaggio Ulderico Pesce. Poi la ragione psicologica: l’ingiustizia di vivere al sud, «rabbia e la voglia di riscatto che mi sentivo dentro». E poco importa se stare al Sud e fare il suo lavoro è più difficile: «Ho fatto le cose per istinto e non per calcolo – dice – So bene che è molto più complicato, che ci sono poche strutture in mano sempre alle stesse persone». Eppure, rimarca, «sono felice di essere radicato al sud, di fare qui i miei laboratori e avere qui il mio archivio». Insomma, «al sud c’è più humus per il mio lavoro, più anima, più materia emotiva per la scrittura – confessa Pesce – e poi qui il mio lavoro ha più senso». Si spiega così: «Al nord non si può salire sugli alberi perché ti prendono per matto. Io qui appena posso ci salgo, e mi sento parte di questo mondo». Eccola l’anima del Sud, «la forma mentale di essere Sud», secondo Ulderico Pesce. E allora «io voglio rendere un po’ più Sud anche il Centro e il Nord».
La risposta a tutto questo sta nel brigantaggio, dice Ulderico Pesce. «Sono fiero di essere nato in Basilicata, il posto in cui il fenomeno è stato più forte», rivendica. «La risposta sta in una nuova forma di brigantaggio – sottolinea – quello dei movimenti che qui al Sud sono vivi e difendono il territorio e chiedono diritti. Movimenti che devono essere autonomi dalla politica – insiste – ma che devono organizzarsi e darsi una forma per cambiarla, contaminarla», per entrarci insomma con le proprie parole d’ordine. «I movimenti sui territori devono diventare forza politica – rimarca l’attore lucano – senza leaderismi, ma senza perdere altro tempo prezioso: in questo Paese la gente perbene sta all’opposizione e deve potersi esprimere». I riferimenti vanno trovati nella letteratura e nella poesia. Rocco Scotellaro, innanzitutto. «Un poeta contadino – lo ricorda Ulderico Pesce che sul suo lavoro e della poetessa Amelia Rosselli ha anche costruito uno splendido spettacolo “Contadini del Sud” – un sindaco, un occupatore delle terre. Diciamo che è stato un politico con un’impostazione poetica e un poeta con una coscienza politica: un vero punto di riferimento». E poi Corrado Alvaro, «il Pirandello delle novelle dei primi del secolo di Ciaula scopre la luna», il poeta suicida Franco Costabile «che amo molto e che ho sentito citare ai ragazzi del movimento ambientalista di Amantea». Prova a tenere insieme tutto questo mondo Ulderico Pesce con il suo lavoro, nella scrittura e nella scena. Lo spiega in maniera appassionata: «Ho scelto di fare questo teatro per due ragioni: una artistica e una psicologica». La prima «riguarda i miei studi». Un giorno al teatro Ateneo della Sapienza a Roma Ulderico Pesce incontra Anatoli Vassilev che lo porta a Mosca. Si ferma lì più di tre anni a studiare e praticare «un teatro semplice, povero, strutturato sulla verità e sulla necessità delle emozioni», a lavorare sul Metodo Stanislavskij «secondo il quale un attore deve essere sempre vero, credibile. Tutto il contrario della tradizione artificiosa del teatro italiano». Così tra il teatro italiano «e mio nonno che faceva l’arrotino, ho scelto mio nonno e i suoi racconti. Prima li ho portati in giro in Basilicata – racconta – poi ho capito che interessavano anche a Roma o a Milano». Così ha trovato il suo linguaggio Ulderico Pesce. Poi la ragione psicologica: l’ingiustizia di vivere al sud, «rabbia e la voglia di riscatto che mi sentivo dentro». E poco importa se stare al Sud e fare il suo lavoro è più difficile: «Ho fatto le cose per istinto e non per calcolo – dice – So bene che è molto più complicato, che ci sono poche strutture in mano sempre alle stesse persone». Eppure, rimarca, «sono felice di essere radicato al sud, di fare qui i miei laboratori e avere qui il mio archivio». Insomma, «al sud c’è più humus per il mio lavoro, più anima, più materia emotiva per la scrittura – confessa Pesce – e poi qui il mio lavoro ha più senso». Si spiega così: «Al nord non si può salire sugli alberi perché ti prendono per matto. Io qui appena posso ci salgo, e mi sento parte di questo mondo». Eccola l’anima del Sud, «la forma mentale di essere Sud», secondo Ulderico Pesce. E allora «io voglio rendere un po’ più Sud anche il Centro e il Nord».
Articolo pubblicato su Terra, 9 gennaio 2011
BOX
È il novembre del 1878 quando Giovanni Passannante, giovane cuoco della Basilicata, vende la propria giacca per otto soldi per comprare un coltello. Vuole uccidere il Re d’Italia, Umberto I. Non ci riesce, gli procura solo qualche graffio. Viene però condannato a morte, poi graziato e spedito in una cella del carcere dell’isola d’Elba che sta sotto il livello del mare: qui si ammala e inizia persino a mangiare i suoi escrementi. Viene poi mandato a finire i suoi giorni in un manicomio criminale. Muore nel 1910. Gli viene negata la sepoltura e il suo cranio viene esposto nel Museo Criminologico di Roma.
Da allora Passannante finisce nel dimenticatoio, fino a quando Ulderico Pesce non si mette in testa di avviare battersi per dargli una degna sepoltura. Vince: nel 2007 i resti di Giovanni Passannante vengono portati e sepolti a Salvia di Lucania, il suo paese d’origine. Un paese che nel frattempo ha cambiato nome e ancora oggi si chiama “Savoia di Lucania”.
Questa incredibile storia Ulderico Pesce l’ha raccontata in un fortunatissimo spettacolo (che ha girato importanti festival in tutto il mondo) dal titolo “L’innaffiatore del cervello di Passannante: l’anarchivo che cercò di uccidere Umberto I di Savoia”. E oggi è diventata un film, “Passannante”, per la regia di Sergio Colabona, nel quale insieme a Ulderico Pesce recitano il cantante dei Tetes de Bois Andrea Satta, Bebo Storti, Roberto Citran e molti altri artisti. Il film è stato selezionato per il Bari International Film e Tv Festival diretto da Ettore Scola e Felice Laudadio (22 – 29 gennaio) che sarà presentato domani (10 gennaio) alla Casa del cinema di Roma.