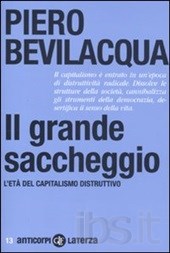Cinque anni fa. L’idea di raccontare la storia di Peppe Valarioti è di cinque anni fa, anche la prima intervista è di cinque anni fa. Un giorno di fine estate del 2005 siamo stati a Vibo Valentia per incontrare Peppino Lavorato, mitico sindaco di Rosarno ed ex parlamentare antimafia. Non lo conoscevamo di persona. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la storia di Peppe Valarioti, ucciso dalla ‘ndrangheta a Rosarno a trent’anni. Gli è morto tra le braccia Peppe. Ascoltando le sue parole ci siamo subito resi conto di quanto fosse doloroso quel ricordo, e di quanto tuttavia lo sentisse necessario e urgente. Una conversazione decisiva: così la nostra idea è diventata l’inizio di un percorso arrivato fino a oggi.
Peppe Valarioti meritava di essere raccontato. Perché tutte le vittime innocenti della ‘ndrangheta hanno diritto al ricordo e alla memoria. E anche perché Peppe Valarioti è un personaggio straordinario. Davvero. È un precario che vive la Calabria degli anni Settanta, la Calabria dove la ‘ndrangheta spadroneggia e il lavoro scarseggia, le rivolte dei braccianti sono un ricordo sbiadito e la rivoluzione dell’Italia degli anni Settanta la puoi osservare solo da lontano. Dove il futuro è un alibi o un’ipotesi inconsistente.
Peppe è un professore, un intellettuale che come Pier Paolo Pasolini sa leggere la speranza negli sguardi dei bambini e dei ragazzi del suo paese anche quando la speranza non c’è, che sa guardare avanti di vent’anni, che sa dire cose scomode. È anche un uomo che ama il rapporto diretto con la sua terra, che questo significhi lavorare i campi di famiglia o difendere il suo paese dalla speculazione edilizia. Sta con il movimento dei disoccupati, crede che l’arte e la cultura siano strumenti di emancipazione collettiva. Le promuove e le pratica. Sente la politica come un bisogno, come un mezzo per il cambiamento delle condizioni di vita delle persone. La sceglie quando questo significa puntare sulle risorse del territorio mentre Giulio Andreotti promette cattedrali nel deserto prendendo il caffè con i boss. Entra nel Pci quando vuol dire schierarsi senza ambiguità contro la ‘ndrangheta e i comunisti sono nel mirino dei clan.
La storia di Peppe Valarioti è la storia di un’epoca, gli anni Settanta in Calabria, dal sapore unico. I protagonisti sono i disoccupati che si organizzano e chiedono un lavoro e quelli che fanno nascere il movimento antimafia, i politici onesti e quelli corrotti, sono gli ‘ndranghetisti che fanno le guerre e quelli che diventano imprenditori, politici e massoni, sono i morti ammazzati che non hanno giustizia. Una storia, tante storie di trent’anni fa. Che contengono ogni ingrediente della Calabria, dell’Italia, di oggi.
Cinque anni fa. Ragionavamo di noi, della nostra identità di meridionali, di calabresi. Avvertivamo forte un senso di inadeguatezza. Che pensavamo dovesse essere collettivo e che sentivamo innanzitutto come personale, privato. Siamo senza memoria, ci siamo detti. Non avevamo altra scelta che quella di cominciare a scoprire, ricordare, e raccontare. Abbiamo girato in lungo e in largo la Calabria. Abbiamo incontrato tanta gente che se ne fotte. Gente che ha perso per strada la parte migliore di sé, che ha paura, s’è abituata a confondere il diritto con il favore, che coltiva il brutto e si fa imporre dove mettere la croce, che soffre e poi dimentica. Abbiamo incontrato incapaci e corrotti, «pavidi travestiti da intellettuali e carnefici mascherati da censori», venduti e persino svenduti, schiavi, barbe finte e padrini. C’è un vasto campionario, che tutti conoscono.
Siamo andati avanti. Per fortuna. Incrociando molte altre persone eccezionali, nuove storie bellissime. A tutte abbiamo prestato attenzione, cura. È stato un viaggio difficile, pieno di curve e di strade interrotte. Eppure straordinario ed entusiasmante. Un viaggio incompleto, che non dovrebbe avere mai fine come certe tournée dei folksinger americani. Siamo stati dentro la memoria dei calabresi. Con pazienza e rigore abbiamo provato a tenerne insieme i pezzi, a recuperarne sguardi e suoni, odori e colori. Testardamente abbiamo cercato e trovato la meglio gioventù della Calabria, di ieri e di oggi. Forse anche di domani. Abbiamo incontrato chi ha combattuto per i diritti, sociali e civili. Ascoltato dalle voci dei familiari, degli amici, dei compagni il racconto delle storie di chi è stato ammazzato dalla ‘ndrangheta e anche la vita entusiasmante e complicata di chi contro i boss ha avuto la meglio. Tante persone oneste, semplici, perbene. Delle quali ci sentiamo orgogliosi. Abbiamo parlato con i vincitori e i vinti. Tutti dalla stessa parte, però.
Con ostinata partigianeria ci siamo messi al servizio di questo mondo. Travolgente e fragile. Per raccontare, e raccontare. E contribuire alla costruzione di una nuova identità meridionale. Era nata l’associazione antimafie daSud. Un’associazione che cerca di ripensare il modo conosciuto sinora di concepire mafia e antimafia, nord e sud, potere e critica al potere. Che pensa che fare antimafia significhi partecipazione, creatività, rivendicazione di diritti. Che sperimenta modi di essere e praticare Sud.
Dopo cinque anni di viaggio nella memoria di una Calabria che si ostina a dimenticare, arriva finalmente il libro dedicato a Peppe Valarioti. Il caso vuole che mentre lo scriviamo scoppi la rivolta di Rosarno. Ci siamo spesi con grande passione e impegno, spesso in amara solitudine, per riattraversare quelle strade. Ci siamo spesi al fianco dei lavoratori migranti sfruttati nella Piana che fu terra di grandi lotte e conquiste. Farlo è stato un po’ come fare rivivere Peppe Valarioti. Ci sarebbe stato anche lui, senza dubbio, in questa battaglia. È proprio vero: le idee non possono morire, basta voler raccogliere il testimone. “Il caso Valarioti” gode di numerosi privilegi. Contributi preziosi, da leggere e conservare.
Chi nella vita ha deciso di fare il giornalista oggi ha pochi, pochissimi punti di riferimento. Uno si chiama Giorgio Bocca, averlo in questo libro è un onore. Gli abbiamo chiesto di raccontarci come un grande inviato del nord ha conosciuto il sud. S’è accostato a questo progetto con curiosità, umiltà e rigore. Ennesima lezione di giornalismo.
Abbiamo chiesto un’analisi sullo stato del movimento antimafia a Enrico Fontana. Enrico è un giornalista, ha fatto politica ma è un rappresentante della società civile, è l’inventore della parola “ecomafia” e conosce come pochi le associazioni. Offre un punto di vista molto interessante, un ottimo strumento di lavoro.
Chi vorrà leggere questo libro, potrà leggere anche le parole di Giuseppe Smorto, giornalista di razza e condirettore di Repubblica.it. È un reggino, Giuseppe. Con lui abbiamo provato a capire come (secondo noi male) i media raccontano il sud. Ci ha risposto con franchezza, coraggio e lucidità. La conclusione alla quale siamo arrivati ― e che vi invitiamo a leggere ― fa un po’ paura.
La prefazione è affidata a Filippo Veltri, caporedattore dell’Ansa Calabria, per varie ragioni: perché ha seguito da vicino come giornalista i fatti, perché è stato testimone privilegiato delle principali vicende calabresi degli ultimi trent’anni e perché non ha un’idea della memoria e dell’informazione come proprietà privata. È un giornalista bravo, Filippo. E generoso.
È impareggiabile il contributo offerto a questo libro da Carmela Ferro, la compagna di Peppe Valarioti. Le parole scritte per questo libro sono dirompenti. Per verità, passione, amore. Dobbiamo moltissimo a Peppino Lavorato, per questo libro e per l’esempio. Di politico lungimirante, di amministratore coraggioso, di cittadino onesto, di uomo appassionato. A lui, amico sincero, abbiamo chiesto la postfazione e un ricordo di Peppe. Gli abbiamo fatto anche fare la promessa che scriverà la storia della sua vita. Che tutti devono conoscere. Il caso Valarioti chiude un ciclo. Di tutti noi, di ciascuno di noi. Se ne aprirà, speriamo, un altro. Intanto, buona lettura.
p.s.
In un’antologia di Bucoliche e Georgiche Peppe Valarioti aveva annotato una frase molto significativa: “La vita è una guerra totale; pochi tentano di mettere la pace ma sono soffocati dalla mischia”. L’ha scoperta Vanessa, una sua pronipote che ama stare tra i libri dello zio Peppe. Ecco, l’idea è che nel nostro Mezzogiorno si trovi la forza di non restare soffocati.
(introduzione al libro “Il caso Valarioti”)