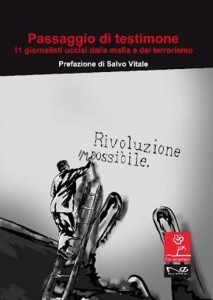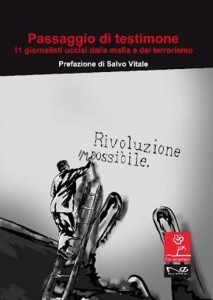 Presentazione del libro “Passaggio di testimone. Undici giornalisti uccisi dalla mafia e dal terrorismo” ( Navarra Editore – 2012, Collana Fiori di campo). I diritti d’autore del libro saranno devoluti alla rivista Casablanca – storie delle città di frontiera, consultabile sul sito www.lesiciliane.org.
Presentazione del libro “Passaggio di testimone. Undici giornalisti uccisi dalla mafia e dal terrorismo” ( Navarra Editore – 2012, Collana Fiori di campo). I diritti d’autore del libro saranno devoluti alla rivista Casablanca – storie delle città di frontiera, consultabile sul sito www.lesiciliane.org.
La serata sarà inoltre un’occasione per presentare i volti e le iniziative che l’Associazione Antimafie “Rita Atria” – Presidio di Roma ha in programma per i mesi a venire tra cui la partecipazione attiva al Comitato No Muos – Roma (presente con una mostra fotografica NO Muos) oltre che per ascoltare attraverso le parole dei/lle giornalist* di Errori di Stampa, storie di chi ogni giorno, nonostante le limitazioni della precarietà, si spende sul territorio per raccontare e informare a schiena dritta.
MODERA: PIETRO ORSATTI (giornalista, scrittore e regista)
INTERVENGONO:
CLAUDIO FAVA (deputato, giornalista e scrittore)
MICHELE GAMBINO (giornalista, saggista)
SERGIO NAZZARO (giornalista, scrittore)
ULISSE (testimone di giustizia, presidente onorario Associazione Antimafie “Rita Atria”)
GRAZIELLA PROTO (giornalista, fondatrice e direttrice della rivista “Casablanca”)
DANILO CHIRICO (giornalista, scrittore)
******************
“Chi ha in mano un testimone – scrive nella prefazione Salvo Vitale, curatore della collana Fiori di campo, cui il libro stesso appartiene – ha una grave responsabilità: non perderlo, non farlo cadere, essere degno dello sforzo del compagno che glielo ha passato, anzi, tentare di far meglio. Le staffette vengono chiuse dagli atleti più veloci. Il passaggio implica un gioco di squadra, una sinergia all’interno di un percorso comune, ma soprattutto una responsabilità individuale”.
Sinergia, gioco di squadra, percorso comune e responsabilità individuale. Raccogliere il testimone e la testimonianza non sembra affatto un’operazione facile, ma estremamente necessaria specie quando la democrazia stessa è minacciata. Raccogliere il testimone e continuare la corsa diventa quindi un impegno e una responsabilità civile cui nessuno può esimersi. La corsa non è conclusa, il passaggio è ancora in corso. A ciascuno di noi spetta questo compito nella quotidianità, continuando a correre, senza fermarsi.
Undici storie, undici persone, undici testimonianze quelle raccontate nel libro edito da Navarra. Undici giornalisti morti per aver scritto, uccisi per aver raccontato. Vittime delle mafie e del terrorismo. Morti per aver voluto, attraverso il giornalismo, svolgere il compito di molesto watch dog del potere oltre che quello di tenere alta l’attenzione su temi e problemi che, sebbene sotto gli occhi di tutti, si preferisce ignorare perché scomodi o rischiosi. Un giornalismo, quindi, che vuole avere un riscontro nella vita sociale del Paese, passando anche per il risveglio critico ed etico della coscienza sociale. A raccontarli altri giornalisti e giornaliste, colleghi e colleghe impegnati su quegli stessi territori, in una sorta di staffetta dell’informazione a schiena dritta.
Un tentativo, quello del libro e di questa presentazione, di andare oltre la vuota retorica celebrativa e guardare all’esempio di quei giornalisti non come martiri eroici di un’informazione che resiste ma come un invito a non rendere vano il sacrificio e l’esistenza stessa di chi ha deciso di intraprendere il mestiere di cronista “in quel modo infaticabile, quotidiano, di raccontare quello che accadeva, di documentare le storie di ordinaria miseria, di spiegare, mostrare, istruire” all’insegna di quel “concetto etico di giornalismo. Un giornalismo fatto di verità, impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, sollecita la costante attuazione della giustizia, impone ai politici il buon governo” di Giuseppe Fava.
Un invito a non rimanere in silenzio, a non chiudere gli occhi e a non voltare le spalle che coinvolge non solo gli operatori dell’informazione ma tutti noi, nel quotidiano. Testimoni e costruttori/trici di Giustizia come Rita Atria, cui non a caso è intitolata la nostra Associazione, Ulisse, che ne è presidente onorario, e sua moglie, come quanti e quante ogni giorno denunciano atti criminosi e illegalità.