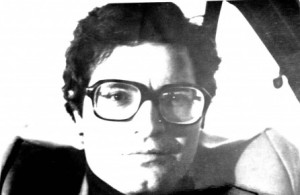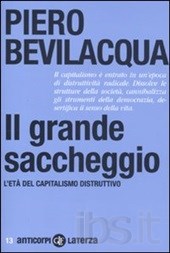E’ il giorno dell’epifania quando viene ammazzato Piersanti Mattarella, il democristiano presidente della Regione Sicilia. Un omicidio grave, gravissimo. Che sconvolge la vita dell’isola e parla al Paese intero.
Piersanti Mattarella è un big, figlio di un big. «È figlio di Bernardo – ricorda Pierluigi Basile, autore del libro “Le carte in regola” (pubblicato dal centro studi Pio La Torre) – l’uomo di potere che ha costruito la Dc nell’isola».
«Essere un Mattarella lo svantaggiava – sostiene Basile – dentro il partito e all’esterno, dove il Pci lo guardava con pregiudizio». Fa una carriera fulminea Mattarella: nel 1967 viene eletto deputato regionale, nella seconda metà degli anni 70 «si rende protagonista di una nuova stagione di battaglie meridionaliste». Divenuto assessore al Bilancio, poi, «inizia un percorso di trasparenza amministrativa, quella che lui chiama “la politica delle carte in regola”. Prova cioè a rompere i lacci e i laccioli del potere politico peggiore e della mafia, a pulire i luoghi del clientelismo». Supera le diffidenze, avvia il dialogo con il Pci (del segretario regionale Achille Occhetto) e fa crescere una generazione di giovani tra cui emerge Leoluca Orlando. Il processo trova sbocco nel ‘78 quando diventa presidente della Regione a capo di un governo che ha anche il sostegno del Pci (che non entra in giunta): “la politica delle carte in regola” diventa quella ufficiale. Punta sulla programmazione e le risorse locali (scrive a Zaccagnini per motivare il suo “no” al Ponte), controlla le spese degli assessorati. Interviene anche nell’edilizia «opponendosi allo scempio del territorio che aveva portato al “sacco di Palermo”». Provvedimenti concreti che restringono gli ambiti di manovra delle cosche e dei ras della Dc. Nell’autunno ‘79 dispone un’inchiesta sugli appalti di sei scuole che a Palermo sono finiti in mano a sei ditte riconducibili al boss Rosario Spatola. Fatti su cui indaga anche il procuratore di Palermo Gaetano Costa, ucciso il 6 agosto.
La situazione è tesa, e Mattarella lo capisce. Ne parla anche al ministro dell’Interno Virginio Rognoni. Si impone la strategia dei corleonesi di Totò Riina e Cosa nostra nel ‘79 uccide il giornalista Mario Francese, il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, il magistrato Cesare Terranova. Il cerchio si chiude con Mattarella.
«Se ragionassimo di fantastoria dovremmo chiederci cosa sarebbe successo se Mattarella non fosse stato ucciso?», si chiede Basile. La storia non si fa con i sé. Ma la Dc, che con Zaccagnini (e Mattarella, destinato a fargli da vice) sembrava orientata a continuare il dialogo col Pci, scelse invece Bettino Craxi.
Chi ha ucciso Mattarella? Si conoscono i mandanti (la commissione di Cosa nostra, i cittadini e i corleonesi, che interrompono il nuovo corso della Regione) ma resta un mistero sugli esecutori materiali. La moglie di Mattarella, Irma Chiazzese, riconosce come killer il terrorista nero Giusva Fioravanti che finisce anche in un’inchiesta di Giovanni Falcone. Forse Cosa nostra e terroristi hanno l’interesse comune a indebolire lo Stato e pensano di poter condizionare gli eventi. Forse non ci riescono, ma certo la Sicilia di Mattarella era diversa da quella di Cuffaro o di Lombardo.